Venezia (Racconto)
Giuseppe Di Grande Aggiornato il 04/10/2006 00:00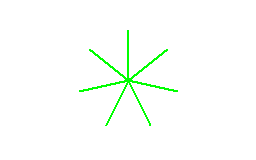
“No visit, only for mess!”, ripete ancora la guardia all'ingresso laterale di San Marco, mentre sciami di turisti vagano affascinati tra le calli di Venezia. È una mera formalità: i visitatori entrano ed escono in e da San Marco come colori e forme in un caleidoscopio. Il vocio della piazza diventa silenzio una volta che i pesanti drappi di velluto, che separano il vestibolo dalla basilica, si richiudono dietro le occhiate stupefatte della gente. Dentro la chiesa, i visitatori, in cerca di una colonna solitaria per poter strappare una Fotografia alla magnificenza del luogo, vengono seguiti dalle guardie che, a fil di labbra e in uno stentato inglese, intimano: “No photo, only for mess”.
Una bambinetta gira intorno ad una grandiosa colonna quadrata mentre un Uomo la guarda bonariamente appoggiato ad una colonna tonda di minor diametro. Una Donna, sofficemente imbellettata, solleva gli occhi dal Ministro di Dio e lancia brevemente uno sguardo sdegnoso prima al padre, poi ai sandaletti della figlia. L'Uomo si passa le dita sulla barba incolta: da essa sembra sprigionarsi una malia salmastra. Il fluido per un breve attimo sgrana gli occhietti alla Donna che, come spinta via da una breve e forte onda lagunare, sozza di umanità e forte di ricordi, viene riportata sognante all'altare.
L'atmosfera comunque non si accorge di nulla: i pulviscoli dorati che aleggiano nell'aria continuano a danzare mentre il sufficiente profumo di incensi continua a misticizzare le parole sacre che vengono fuori da piccoli altoparlanti polverosi.
Un luogo simile può definirsi sacro? L'arte che distoglie l'attenzione anche della più ferrea fede può essere un tramite per arrivare a Dio? Lì è tutto come la luna che si specchia a metà due volte negli occhi della gente.
Un ragazzo, dopo aver accarezzato un'acquasantiera, si incammina timidamente verso il vestibolo. Oltrepassa i pesanti drappi vellutati e si ferma ad osservare l'alta volta. Poco dopo viene raggiunto da una ragazza che scatta, click Digitale, qualche foto agli angeli e ai demoni che ivi si incontrano e si scontrano in una perenne pantomima, a voler allietare i turisti. Chissà se, al chiudersi di tutti i portali della basilica, quelle figure scendano dal loro palcoscenico e percorrano le callette notturne e malfamate della bella Venezia, in cerca di un bacaro e di tanti cicheti che facciano loro dimenticare la parte che impersonificano durante il giorno.
Le guardie all'entrata laterale continuano ad informare i visitatori o i fedeli a quali condizioni si può entrare a San Marco. Le persone, nonostante tutto, entrano annuendo come bimbi al primo insegnamento di un maestrino disilluso. Poi le stesse, quando escono, lasciano un sufficiente buongiorno o buonasera o arrivederci, quasi come a manifestare una mal celata indignazione per non aver potuto portare a casa una prova fotografica della loro visita in basilica.
Gli archi della cattedrale sovrastano la calca che passeggia in Piazza. In groppa al leone un bimbetto piange, mentre la madre tenta da poco distante di fotografarlo. Un Uomo Anziano dalla barba rada e dai capelli canuti, di fronte al muso del leone, sembra quasi guardarlo nel profondo degli occhi, mentre con la mano forte e leggermente chiazzata gli accarezza le fauci. Una Donna biondiccia e ingioiellata, forse la moglie, lo tiene per un braccio, imbronciata, timorosa che la bestia in pietra possa portarglielo via.
Venezia è magia, nera e bianca, per ricchi e per poveri. Quella magia che si incontra tra gli zingari, dentro un carrozzone, di fronte ad una stravagante chiromante dove individui di qualsiasi classe si recano per risolvere qualche problema della propria anima. Una zingara che con la Voce bassa, roca, soffusa da un alone bluastro, accompagna i clienti tra le creature goticheggianti, al confine tra conscio e inconscio ghignando e abbandonandoli soli alle loro scelte.
Venezia magica, nell'attimo in cui il sole sospeso in fondo ad un canale riempie gli occhi dei viandanti di chiaroscuri arcani, nell'attimo in cui si intravede la soglia dove il dì e la notte si incontrano per scambiarsi la maschera con un bacio. Eterea, coi suoi artisti di strada, invidiati dalle anime che si credono libere, mentre si esibiscono, e allontanati subito dopo aver suonato l'ultima nota, dopo quell'applauso finale, sola riconoscenza al Colore che regalano ai canali. Bande che magari terminano un “Nessun dorma” pucciniano e iniziano un “Ciuri ciuri” siciliano, orchestrine equidistanti dai tavoli di due bar che presentano agli avventori un supplemento musicale di non ben chiara provenienza.
È piazza San Marco, con al centro i venditori di granoturco per i piccioni, le ombre sotto la merlata del Palazzo Ducale e i cavalli in restauro. Più in là il bacino, colle gondole più prestigiose, un matrimonio, i gondolieri più anziani che non sanno più Riconoscere un veneziano da un campagnolo, il Ponte dei Sospiri dove ogni turista perde anche quel pizzico di egoismo improvvisandosi fotografo di coppiette senza nome, la compravendita di ammennicoli sul ponte di Rialto o in uno dei tanti campi o campielli, fermate come grani di un rosario tra le dita di una vecchia credente.
Stormi impressionanti di piccioni svolazzano rapidi da un chicco all'altro di granoturco, tanto da indurre qualche persona a ripararsi il viso con le braccia. Uno dei piccioni si stacca dal gruppo e si scaglia verso il leone in pietra. Terrore. La farfalla scatta con un colpo d'ali a sinistra, poi in basso tra le gambe dell'Uomo canuto, una esse sbilenca per aggirare il bambino e subito una curva sotto la pancia del leone. Il volatile si abbatte diretto sul fianco della statua rimanendo a terra per qualche secondo, intontito tra le risa della gente. I pericoli a Venezia sono tanti, troppi, invisibili, travestiti e confusi tra i turisti, tra i souvenir, appollaiati ad un cornicione o ad un davanzale, in attesa sapida dietro un angolo di un campiello isolato. Si percorrono calli piene di gente, ma se si svolta a destra, piuttosto che a sinistra, o invece d'andar dritto, ci si ritrova a calpestare mattoni malfamati, a sentirsi stringere addosso porte senza nome, ad accelerare il passo perché uno scricchiolio risuona come un sinistro avvertimento, a fermarsi smarriti, a srotolare per l'ennesima volta una piantina di Venezia, cercarsi ansiosamente, e purtuttavia rendersi conto di aver perduto un senso per averne acquisiti altri: angoscia, paura, terrore.
Una Donna velata passeggia per una di quelle callette poco conosciute, incontra un Uomo che la guarda disperato, si scambiano qualche parola in lingue diverse, per pochi attimi due ceti estremi condividono la medesima vita, poi la Donna mascherata, forse una prostituta, indica un'uscita sorridendo. L'Uomo la ringrazia come può e sa fare, sembra quasi sincero, si allontana, dopo qualche metro si volta, ma la Donna non c'è più. Il forestiero razionalizza qualcosa, per non impazzire, e continua per la calletta, fino ad una calle, e ad ogni passo quella Donna si trasforma, si dilata o si restringe, impallidisce e infine sparisce: non è mai esistita.
A Venezia ci sono leggende che aleggiano prima dei fantasmi che raccontano. Forse quella Donna non è una prostituta, ma una futura sposa vestita ancor di bianco. Forse è la giovine che volle raggiungere lo spirito del suo amato, annegato nello stesso canale per mano della gelosia del padre. Chissà quale ridda di pensieri prima del gesto estremo, ironico, sarcastico, insolente come una smorfia all'immortalità. Chissà se l'acqua ebbe un sapor ramato come le dolci lettere del suo epitaffio. E chissà se ora sia felice nel suo eterno carnevale. D'altronde Verona è vicina e le leggende per osmosi potrebbero tornare dalla campagna, ma qui a Venezia, gli anziani del luogo giurano, indice e medio sulle labbra, di averla Vista vagare di notte in quella calletta silenziosa dove secoli prima, non si sa bene quando, si incamminò verso le acque confortevoli del canale di Santo Spirito, non ancora inflazionato.
Tra i merli del Palazzo Ducale i raggi rossi del sole rischiarano le sparute testoline dei piccioni che ivi giacciono per pochi attimi, per poi rituffarsi nella calca fatta di Uomini e volatili. Al di là, la farfalla plana come una foglia fino ad un lato dell'imbarcadero e osserva un Uomo seduto per terra, vestito di variopinti e laceri cenci che chiede l'elemosina ai tanti, troppi passanti. Ogni tanto si gratta la barba ingiallita, cornice ad una chiostra di denti ancor più scuri, e poi si passa le dita sugli occhi, come a sottolineare la sua infermità. In un cartello, poggiato sul ventre, a grandi lettere sbilenche, che forse raccontano le disavventure dell'Uomo a chi sa Leggere tra aste, curve e punti, giacciono i saliscendi di una grafia travagliata. “CIECO”, è l'unica sequenza di lettere nel cartello, avida ed ermetica parola che fa da tramite al barattolo marinaro più in basso e alle mani della gente più in alto. Ogni tanto qualcuno gli lascia cadere un obolo. Ad ogni tonfo il cieco sussulta, abbassa con pesantezza le palpebre, ringrazia in un fil di Voce, poi stringe le labbra. Sembra quasi diventar più grigio, come se volesse confondersi con le tante gambe che lo sovrastano. A volte sembra permeato da una diafanità imperfetta, quasi fosse una reminiscenza del passato, ricordo di una Venezia antica che stenta a dimenticarlo. Alcuni adulti affermano di non averlo neppure visto. Quando qualche piccolo lo punta col dito tirando nel frattempo la camicia del genitore, quest'ultimo lo zittisce cantilenando bambinescamente di star buono, pena il divieto di fare il giro in barca.
La farfalla vola tra le tante teste ammassate all'imbarcadero. Un Uomo da un vaporetto urla che non c'è più posto. Le teste si fermano e aspettano il prossimo. Più in là, poche e sparute persone chiacchierano dentro una navetta. “No stop! Go inside!” urla invece il comandante di un vaporetto vicino. A bordo, la differenza di persone che c'è tra le due imbarcazioni, marca i gusti grossolani della gente.
Il comandante della navetta accende i motori, due o tre sfuriate di acceleratore, lo scafo va indietro, avanti, si stacca dalla banchina e comincia a muoversi per la laguna. Si lascia alle spalle le bancarelle di souvenir e i passi della gente che percorrono le calli. Anche se il rumore dei motori è l'unico frastuono che si ode, il silenzio della laguna pare dominarlo.
I turisti della navetta abbassano la Voce, forse per non disturbarsi a vicenda, forse per qualche sensazione inconscia o forse per Ascoltare il mormorio delle acque lagunari che si frangono nelle banchine dell'ultimo canale. Come un vecchio, le rigide mura delle costruzioni, sentono la carezza perenne delle onde, per un breve attimo distolgono l'attenzione dai loro pensieri, un sorriso, e poi tornano stanche a fissare nuovamente la loro millenaria staticità. Il tempo dei desideri è ormai passato.
Lì in fondo, ultima costruzione neogotica del canale della Giudecca, c'è il vecchio mulino Stucky. Lo stanno ristrutturando per farne un moderno e lussuoso albergo. Se un visitatore si ferma per la notte forse potrà sentire ancora l'odore di antiche semenze. Forse udrà pure l'attracco di grandi imbarcazioni fantasma che scaricano le loro stive direttamente dentro il quinto piano del grande mulino, o il crepitio di fiamme insieme allo sfrigolio di torrenziali granaglie che scivolano giù fino ai magazzini. È bene chiudere gli occhi poiché la Vista non godrebbe di alcuna visione. Qualche asse di carpenteria, qualche cartaccia, qualche siringa. I fasti appartengono sempre al passato, anche perché la paura e le speranze sono del domani in ristrutturazione.
Gli scafi tagliano la laguna come delle lame una Pelle incartapecorita. Questa si apre per un breve attimo con qualche debole sfilacciatura perlacea e poi si richiude sinuosamente come olio rancido. Le briccole, dritte d'orgoglio, delimitano in controluce le acque navigabili da quelle insidiose. Nelle nottate di burrasca amoreggiano col vento, cantando come sirene, calandosi in un ruolo che non gli appartiene in cerca di qualche moroso abbandonato al sacrificio.
In lontananza, di fronte la navetta, gli alberelli di un'isoletta si stagliano fieri sulla curva verdeblu dell'orizzonte. La navetta punta sull'isola di San Clemente, a sud della Giudecca. Si respira già l'odore di vecchie vestigia confuse con quelli di un lussuoso albergo a cinque stelle. A lato dell'imbarcadero dell'isola un promontorio Artificiale imbiancato di ghiaia si alza goffo a mostrare un gazebo e una panchetta, meta di innamorati ospiti dell'albergo. Ad osservarlo da lontano sembra un mausoleo, biglietto da visita dell'isola. San Clemente sussurra silenzio da ogni dove. I frati camaldolesi a ragione la scelsero come eremo. Fu monastero, fu complesso conventuale, fu un forte napoleonico, fu anche manicomio, e ora fa da albergo, come a voler con frizzi e con lazzi seppellire le anime che ivi vagano nel tentativo di spezzare il filo con la propria vita, passata, presente o futura.
Un signore impettito, mento puntuto, scende dalla navetta e saluta una ragazza, forse una cameriera o una inserviente, con vocetta nasale di dirigente cresciuto a forza di sissignore. La ragazza passeggia desolata per i vialetti, guardandosi a destra, a sinistra, come se fosse in cerca di qualcosa che non ha ancora riconosciuto. Più in là una coppia a braccetto si appresta a prendere un tavolo della veranda del ristorante. Scostano due sedie in vimini, l'una di fronte all'altra, e si siedono. Chiacchierano, parrebbe amabilmente. D'un tratto un tremito sbianca l'aria, ma dura poco. I colori velocemente ritornano e e un sorriso a labbra strette riappare, le due mani si stringono e i grilli rossi sul tramonto di Venezia riprendono gli esercizi per la serata che li aspetta.
La farfalla nota che un viottolo pare soffuso di una tenue luminescenza. Mentre un dito la punta e poi una mano tenta di ghermirla, si alza di scatto, un flemmatico colpo d'ali, e lo segue, allontanandosi. Vola su uno sterrato, sempre più in abbandono man mano che ci si lascia dietro le mura spesse dell'albergo, e zigzagando va avanti, attratta da un Colore, da un Suono o da un odore.
Al margine d'una curva spunta correndo un bambino, magro, vestito di panni poveri e antichi che al vederla si blocca, fissandola. Dopo qualche attimo guizza via lasciandosi dietro una scia luminosa e delle parole annunziatrici che echeggiano per l'aria in una vecchia Lingua. Da un'ala lontana dell'albergo arriva un picchiettare monotono, lento, come un dito che batte su una finestra. “Tum. Tum. Tum.”, si ferma. “Tum. Tum. Tum.”, ricomincia. D'un colpo uno schianto, come di vetri infranti. Silenzio. E poi un brusio, come bisbigli, ove si odono tanti nomi, tutti i nomi del mondo. Di fronte al sentiero c'è una antica chiesa, davanti tante persone che aspettano. I nomi sono i loro, traslucidi come la parvenza di ricordi che esibiscono ancora coi loro corpi immateriali d'ogni epoca, d'ogni genere, d'ogni ceto e d'ogni razza.
Un signore fa un inchino. Altri lo imitano. Sono talmente tanti che paiono onde. Il sole è ormai calato dietro lo sfondo di Venezia e il cielo sfuma dal viola al blu via via che lo sguardo corre da occidente ad oriente. Un cuore sembra pulsare proprio lì, dentro quella chiesa millenaria che ha visto alzarsi e cadere la Storia di quell'isola. Si apre un varco tra le anime e, sulla soglia della chiesa, c'è il bambino che, seduto sul terzo gradino, con il palmo sul mento e gli occhi allegri, è in evidente attesa. Gli altri spostano lo sguardo alla farfalla, poi a lui, per tornare a lei, o ancora più lontano, forse a qualcuno che giace seduto sul tempo e attende quell'attimo in cui il senso gli sarà rivelato, in cui capirà perché le mani si fermano prima di un gesto, o perché si desiste dal camminare, o perché si continua a cercare, nonostante tutto, o perché alcuni sconosciuti sembrano così vicini. Come se si affacciassero da uno specchio, annuiscono lentamente, un invito a guardare dentro la liscia superficie per scoprire che esistono altri mondi, altri esseri, altre realtà, altre farfalle. È un quadro onirico.
La farfalla è ad un metro dal bambino. Questi si alza. Si guardano, battono le ali. Poi lui si gira ed entra in chiesa. Il chiarore si fa più intenso. Lei lo segue. All'interno, al loro passaggio, le persone che furono si aprono, mentre quelle dietro si fanno più vicine. Le indicano null'altro che la strada. Se lei ora facesse come per cambiare direzione non avrebbe altre vie, perché ora non ci sono altri sentieri, il labirinto è ormai superato. Gli affreschi scrostati brillano di luce propria, il mormorio si carica di attesa come le vibrazioni di un carillon in procinto di gioire. La luce è spirito, e i pazzi che furono di quel manicomio lo sanno. Quelle persone che viaggiarono per l'universo in cerca di nuovi mondi mentre le catene li liberavano. Quelli che sentirono le vibrazioni delle stelle mentre i loro organi si disfacevano parlando senza senso in altre lingue. Quelli che venivano risvegliati dalla musica e urlavano di disperazione e imploravano ai loro aguzzini: perché, perché, perché mi hai svegliato. Ora i loro nomi per ricordare e non sbagliare, una cacofonia di nomi, tutti i nomi del mondo, il nome e per nome del mondo tutte le sette note a risuonare in tutte le tonalità.
Dalle antiche tombe con indecifrabili scritte in latino, alcune distrutte da vandali, in lente e sinuose onde di plasma si alzano nuove anime. Si forma un viso sorridente che dopo breve si disgrega per trasformarsi in altri episodi di vita che fu. È un evento, è quell'attesa protrattasi di vita in vita, da un riposo all'altro.
A sinistra qualche stanza che porta a gradini che scendono in altre cripte polverose e misteriose. Innanzi un altare con una croce che pare sospesa su di esso. A lato dell'altare qualche sedia rotta dell'albergo. Dicono che qualche stanza viene usata come deposito. In lontananza si avverte l'odore di bucato appena lavato. A destra altri antri. Le anime si allargano. Da lì la luce pare più tenue. Vogliono che lei vi entri. E lei nuota in quella direzione.
In fondo si intravede qualcosa. All'avanzare del bambino viene svelata una statua della Vergine. Il bambino le si ferma di fronte, poi si gira come per aspettare la farfalla. Quando lei è a non più di sette passi umani il bambino china il capo e svanisce. La statua della Madonna si infonde di un'aura multicolore. Le pieghe azzurrine della veste ondeggiano come mosse da una leggera brezza. Il braccio del bambino che tiene al petto è spezzato come se fosse un marchio distintivo del disagio di tutto quel luogo.
La farfalla batte le ali. Tra gli spiriti si alza lo stupore, come tante vocali “O” che ritornano dalle mura e si intrecciano e poi si interpolano in mille tonalità. Per un breve attimo non c'è alcun nome, tutti risuonano con l'essenza della farfalla, e ogni volta che le ali raggiungono le estremità del mare, quel Suono come un mantra diventa più forte avvolgendola di serenità.
La luce della Vergine si fa più intensa. È un globo che si irradia dalla statua e avanza fino a sfiorare le ali della farfalla. La testa del bambino trema leggermente. Poi si muove. Si scosta dal petto della madre. Da ogni oggetto, da ogni angolo, da ogni dove scoppiano barbagli di luce che velocemente si allargano a formare nuovi universi. Ora la Vergine è una fonte inaccessibile, accecante. Ma non per le vite a cui lei a teso la mano. Non per la farfalla. Così come è in basso, così è in alto. Infinitamente, nel ciclo infinito del tempo.
Giuseppe Di Grande
(Racconto apparso su Biblos Teller 1)
