L'Ingresso in Istituto - Da “Un Cieco che Vede” del prof. Antonio Greco
Antonio Greco Pubblicato il 24/02/2021 08:00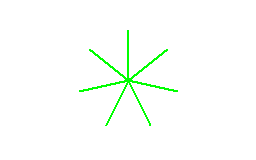
Passati i primi approcci, si cominciò a pensare all'attività lavorativa di mio padre: si fece costruire una cassetta di legno che poteva avere le dimensioni di cm. 70 per 50 e altezza 30 circa. Si fornì di merceria leggera: cotone, bottoni di vario genere, elastico, mollette per i capelli ed altro e riprese la vita di ambulante. Si fece montare sulla bicicletta nuova un bel portabagagli e cominciò a lavorare.
Quando arrivò il mese di agosto e settembre, lasciò la merceria a casa e si dedicò ad un'altra attività: rilegare la saggina in scope domestiche, costruire cesti di paglia di grano con giunchi di paludi con cui produceva cesti anche molto grandi del diametro di circa un metro e altezza di circa 1,50. Riusciva così a sbarcare il lunario della famiglia senza toccare i risparmi africani coi quali si pensò subito di acquistare una casa. Le occasioni non mancavano, poichè c'era gente che aveva costruito l'abitazione a debito e, non riuscendo ad estinguerlo, era costretta a vendere. I miei puntarono l'attenzione su una casa in via G. Verdi costituita da due vani di m. 5 per 5, e un orto retrostante. Si accordarono sul prezzo e decisero di acquistarla. Si fissò così il giorno della stipula col dr. Giuseppe Monosi che ne era il proprietario. Mio padre e mia madre si erano accordati di intestarla ad entrambi, ma quando arrivò l'ora dell'appuntamento mio padre, che era in giro nei paesi col commercio ambulante, non arrivava. Il notaio era pronto e allora non si facevano troppe cortesie. Il venditore decise di stipulare anche in assenza di mio padre, intestando l'abitazione solo a mia madre.
Mio padre aveva fatto ritardo per una imprevista foratura, e quando arrivò ormai era tutto concluso. Egli rimase molto male per essere stato escluso dalla parte della proprietà che con tanti sacrifici aveva guadagnato. Bisticciò con mia madre che non aveva nessuna colpa, poichè allora decidevano i potenti. Per qualche giorno non si rivolgevano la parola. Poi mia madre pensò di fargli un testamento in modo da rassicurarlo. In questo modo si placarono le acque.
Andammo tutti a visitare la nuova casa che veramente offriva nel suo piccolo più agevolazioni di quella in cui ero nato io. C'era la cisterna con l'acqua. In seguito costruimmo una piccola Cucina col focolare un po' sollevato in modo che sotto si poteva usare come piccolo deposito di legna. Nel Giardino vi erano piantate due viti, una di uva bianca e una di uva nera, che vennero avviate a formare un piccolo pergolato sulla terrazzina della Cucina; in fondo al Giardino si presentava una uscita sull'altra strada parallela. L'infisso era abbastanza trasandato e io già pensavo di poterlo riparare. Vi erano anche tre alberi di melo cotogno che ossigenavano il Giardino. Accanto a noi, dalla parte sinistra, quando si entra in casa, abitava la famiglia di Nuzzo Antonio, macellaio, con molte figlie e un solo figlio maschio. Dall'altra parte, invece, c'era una bella casa abitata da una famiglia il cui padre, già vecchio, era privo della vista. Aveva studiato per qualche anno, quando era ragazzo, all'Istituto dei ciechi di Napoli un po' di Musica, e ne aveva fatto gran tesoro. Infatti aveva lavorato suonando col figlio Giuseppe chitarra e violino sui treni, nei locali di un certo lusso in città e si era fatta una bella posizione economica. Le altre case della strada erano abitate tutte da contadini o quasi; faceva eccezione un calzolaio e qualche piccolo mercante. Ormai eravamo vicini all'inverno e si decise di trasferirci alla nuova casa durante la prossima estate.
Io continuavo a giocare con le mie costruzioni e coi miei giocattoli, quando un giorno arrivò una lettera da non so dove. Mia madre in quel periodo faceva la tabacchina nelle ditte locali. A mezzogiorno disponeva di quasi un'ora di intervallo. Venuta a casa, le mostrammo la lettera che cominciò a Leggere: diceva che al figlio Antonio era stata concessa l'autorizzazione a fare il suo ingresso in Istituto dei Ciechi per la "Educazione e rieducazione".
Io, lì per lì, rimasi confuso, ma avevo sentito parlare che in Istituto si studiava e che si apprendevano tante cose. Mi ricordai di ciò che si era detto parecchi anni prima, ma non mi spiegavo come questa lettera era arrivata inaspettatamente. Poi mio padre ci spiegò che quando era in Africa, un suo superiore, appresa la nostra situazione familiare, aveva deciso di dargli una mano e, dato che mio padre era anche "Camicia Nera", riuscì a trovare ascolto anche alla Federazione fascista di Lecce che gli istruì subito la pratica. Così l'Istituto mi mandò l'invito a presentarmi il 16 dicembre, era l'anno 1938.
Ma in quei giorni mi capitò un piccolo Incidente: mentre ero seduto, per il freddo, accanto al focolare con le mie sorelle e col fratellino, non so come, mi cadde un recipiente d'acqua bollente sul piede sinistro. Emisi un grande strillo per il pungente dolore. Subito si prese un altro recipiente con acqua fredda per cercare di lenire il danno e il dolore. Continuai per parecchi giorni in quella posizione; non vi erano altri medicamenti. Tutto il piede si era coperto di una enorme bolla; ma dopo giorni si vedeva qualche segno di miglioramento, finchè arrivò il fatidico 16 dicembre della partenza per l'Istituto. Io, mia madre e mia zia Lucia andammo a piedi fino a Martano dove c'era un carrettiere che trasportava persone con la trainella tirata da un Cavallo. Mio padre, invece, venne a Lecce con la bicicletta. Punto d'incontro era la locanda dove sostava il mezzo di trasporto.
Prendemmo posto sul carro, sul secondo sedile. Quando fu tutto pronto il mezzo si mosse per la volta di Lecce. I passeggeri intanto chiacchieravano del più e del meno. Una ragazza, sui 18-20 anni, che era sul sedile dietro di noi, cominciò a canticchiare una canzone che io non avevo ancora sentito: "Vento". diceva: "Vento, portami via con te...." Aveva una bella Voce. Le chiesero dove aveva imparato quella canzone e lei disse che faceva la cameriera presso una famiglia di Lecce, dove poteva Ascoltare la radio e il grammofono.
Io, pertanto, ero assorto nei miei pensieri: chi sa come sarà l'Istituto? Chi ci sarà? Saranno bravi...? E quando tornerò alla mia casetta dove ho lasciato il fratellino Narduccio di quasi due anni e mezzo? Ero preoccupato soprattutto per lui. Temevo che gli potesse capitare qualche Incidente, data la sua età e la scarsa protezione di cui poteva usufruire, poichè mia madre lavorava alla ditta di tabacco; Rocco era impegnato con la campagna insieme con mio padre, quando questi non esercitava l'attività di ambulante; Neve era di appena 13 anni e Uccia di 16. Intanto il Cavallo aveva rallentato il passo. Forse era stanco e si prendeva un po' di riposo.
Mia madre era silenziosa; forse pure lei pensava al momento del distacco e all'incognita del mio futuro tra mura sconosciute, tra persone nuove di cui nulla si sapeva. La zia Lucia, di Carattere estroverso, buona e socievole, cercava di distrarre me e mia madre con battute scherzose. Noi ci sforzavamo di non dimostrare il nostro disagio e la nostra sofferenza, fingendo sorrisi sforzati e partecipazione allo scherzo.
Il Cavallo aveva ripreso il suo monotono passo al trotto e dopo due ore e mezza finalmente si intravedeva Lecce. Arrivammo alla locanda e ciascun passeggero si incamminò per la sua meta. Mio padre ci venne incontro, giacché con la bicicletta più veloce era arrivato prima di noi. Per non farmi stancare, mi fece sedere sulla bicicletta che egli conduceva a piedi insieme con mia madre e mia zia. Cominciarono a chiedere per l'Istituto e, dopo varie informazioni, giungemmo in via Scipione De Summa. Suonarono il campanello ed il portiere aprì. Gli mostrarono la lettera d'invito ed egli ci fece attendere e chiamò chi di competenza. Venne una ragazza molto cortese e disinvolta che sbrigò i preliminari, assicurò i miei della sanità dell'Ambiente, cercò di tranquillizzarli (ormai era esperta di tali circostanze) e assicurò che la prossima settimana potevano riprendermi per fare le festività natalizie in famiglia. Era quasi mezzogiorno e i miei si accomiatarono. Mia madre nel baciarmi mi bagnò il viso di lacrime. Io già da allora mostravo un Carattere forte. Riuscii a non piangere, e dopo seppi che tutti i bambini o quasi, nello staccarsi dai familiari piangevano e rimanevano tristi per parecchie ore. I miei se ne andarono e la sig.na Formica (questo era il suo cognome) mi condusse al primo piano dove un'altra signorina dall'apparenza più gentile ancora, mi coccolava e mi faceva domande. Seppi poi che era una non vedente Insegnante elementare di nome Rita Marengo. Mi fecero toccare un pianoforte e mi mostrarono come, premendo i tasti, questi emettevano un Suono. Io manifestai subito le mie tendenze inconsce e le mie attitudini musicali. Col palmo della mano suonavo i tasti bianchi e con le dita quelli neri, dividendo quella Musica in due tempi pari al due quarti. Evidentemente creai l'impressione nelle mie ascoltatrici di conoscere già lo strumento, poichè mi chiesero se a casa avevo il pianoforte. Io dissentii, ed esse aggiunsero che suonavo come se già lo conoscessi. Mi dissero che gli altri ragazzi erano a Scuola e che me li avrebbero fatti conoscere dopo il pranzo. La sig.na Marengo aprì uno stipo nel muro della sala, prese un pezzo di cioccolata e me lo donò. Cercavano di farmi parlare, ma io mi esprimevo come sapevo. Non conoscevo bene l'Italiano. A casa avevo parlato sempre la Lingua greca da noi allora molto diffusa e solo con persone che non conoscevano tale idioma si parlava il dialetto Leccese, in realtà molto vicino all'Italiano. E mentre continuavano a distrarmi, un campanello interruppe il nostro dialogo e da tutte le parti cominciò a sentirsi un vociare di ragazzi, più grandi, più piccoli e un festoso correre di qua e di là. Era l'ora del pranzo.
Fui accompagnato a tavola dove presi posto in mezzo a due compagni a cui l'assistente sig.na Formica mi presentò. In piedi ci fecero recitare la preghiera e poi ci ordinarono: "Seduti"! Il compagno della mia destra mi disse di chiamarsi Carluccio e quello della mia sinistra, Niso. Mi spiegarono che, essendo venerdì, non si mangiava tanto bene: infatti per primo, pasta e patate. Accanto al piatto, cucchiaio e forchetta; inoltre c'era il pane e un bicchiere col manico di materiale metallico, pieno d'acqua. I compagni mi spiegarono che poi sarebbe arrivato il secondo piatto che quel giorno doveva essere una qualità di pesce che essi chiamavano col muco, perché si presentava abbastanza mucoso. Poi cominciarono a bassa Voce a chiedermi da dove venivo, quanti anni avevo e che classe dovevo fare. Io risposi che non sapevo e che non avevo frequentato nessuna classe. Mi dissero che ero già grande per dover frequentare la prima elementare, ma io tacqui. Finito il pranzo, ci fu ordinato: "in piedi"! E si recitò la preghiera di ringraziamento al Signore. I due compagni mi vollero accompagnare e così feci le prime amicizie. La sala da pranzo era a piano terra e noi ci avviammo al primo piano dove fino alle ore 15 si faceva ricreazione. Carluccio e Niso mi presentarono ad altri compagni e le mie amicizie si moltiplicavano. Erano curiosi del mio cognome "Greco". Molti pensavano che ero venuto dalla Grecia, poichè proprio quel giorno era arrivata anche una ragazzina anche lei di undici anni come me, ma lei veniva davvero dall'Albania. E il mio cognome e questa circostanza li induceva a pensare che Adelaide Gini (questo era il nome della albanese) era venuta dall'Albania e io dalla Grecia. Mi dovetti sforzare di convincerli che quello era il mio cognome, e che però al mio paese si parlava davvero il "greco" e che anche io lo sapevo parlare. Curiosi, mi chiedevano come si dice in greco la tale parola e la tal'altra e io che mi sforzavo di esaudire i loro desideri. E, mentre a gruppi giravamo intorno ad una grande sala, la sala di ricreazione, nuovamente un campanello interruppe la nostra conversazione. Gli amici mi salutarono dicendo che dovevano andare allo Studio per preparare i compiti per il domani e che poi, a turno, dovevano fare Lavoro in Laboratorio, e Musica.
Io rimasi con la mia assistente che mi fece sedere vicino ad un tavolo e sottopose alla mia osservazione una Tavoletta rettangolare di metallo, tutta scanalata. Mi disse che con quella e con un Punteruolo che mi sistemò tra le dita, dovevo imparare a Scrivere. Sollevò il rettangolo sovrapposto della Tavoletta, fissò a due chiodetti una paginetta, abbassò il telaio e mi fece osservare una riga di piccoli rettangolini suddivisi in due file parallele. Mi spiegò che col Punteruolo dovevo premere in uno di quei rettangolini per fare dei punti. Mi aggiunse che un solo punto in alto a destra del rettangolino dovevo chiamarlo "A". Quando si convinse che avevo appreso bene la prima lezione, passammo alla seconda: mi fece Scrivere tre puntini verticali sulla destra, dicendomi che rappresentavano la "L". Io, nel fare quegli esercizi, istintivamente abbassavo gli occhi sulla Tavoletta come se dovessi seguire con la vista l'esercitazione. La signorina mi invitò a stare con la testa alzata, perché mi disse che non potevo seguire con lo sguardo. Era passata un'ora, perché improvvisamente un gran Suono nel corridoio vicino, non di campanello, ma come di una piccola campana dei campanili, mi fece trasalire. La signorina mi informò che quella era una piccola sbarra di metallo, battuta con un martello ogni ora dal maestro Andrisani, per informare insegnanti e ragazzi che era trascorsa un'altra ora. Il maestro Cosimo Andrisani era Insegnante di Laboratorio, ubicato questo accanto alla sala di ricreazione, quindi molto vicino a noi. Ad interrompere ancora la nostra lezione, venne una Donna che mi medicò con calza medica il piede ustionato. Mi procurarono i vestiti dell'Istituto e la biancheria intima e, tra una cosa e l'altra, si fecero le sette di sera.
Come d'incanto, da tutte le porte sbucarono ragazzi e insegnanti. Mi dissero che dovevamo andare in chiesa a recitare il Rosario. A pianterreno, vicino alla Cucina c'era una cappella con banchi e sedie. Ci accomodammo e una ragazza iniziò la recita del Rosario con la partecipazione di tutti. Mi dissero che nel suo piccolo, era una bella cappella di famiglia dei nobili che prima della fondazione dell'Istituto avevano abitato quel palazzo. Era un palazzo in buona parte antico, confinante col muraglione di difesa, oltre il quale avevano allestito il campo sportivo.
Alla fine del Rosario si recitò per tre volte un "Eterno riposo dona a lei, o Signore", anticipato da: "Per la fondatrice di questo Istituto:". Quando uscimmo dalla chiesa, domandai chi fosse la fondatrice. Mi dissero che si chiamava Anna Antonacci, che era una cieca e che era deceduta più di un mese prima, cioè il 7 novembre di quell'anno. Ella aveva fondato l'Istituto nel 1906, aiutata da altre persone benemerite, ma in particolare da familiari. Chi l'aveva conosciuta di persona mi parlava con tanta devozione. Era una persona dedita tutta al mondo dei ciechi. Voleva riscattarli dalla triste posizione Sociale in cui versava tutta la categoria. Mi dicevano che quando faceva qualche viaggio, non tornava mai a mani vuote, ma sempre con giocattoli piccoli e grandi. Mentre conversavamo così ci sedemmo a tavola per la cena. Come al solito, la preghiera prima e dopo, e poi un altro poco di ricreazione prima di andare a letto.
I capitoli tratti dall'autobiografia "Un Cieco Che Vede" del prof. Antonio Greco, vengono pubblicati con l'autorizzazione dell'autore. Per contattare il prof. Antonio Greco e per informazioni sull'opera completa si può Scrivere a griconio@gmail.com
